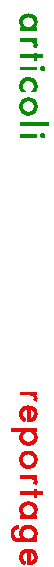
|
Articolo
22 luglio 2020 - Interni - Italia - Panorama |
|
| Il covid degli oggetti perduti |
Fausto Biloslavo
Il telefonino con i video e le foto ricordo di una vita perduti per sempre. La fede ritrovata dopo tre mesi e mezzo, gli occhiali, le pantofole, il rasoio elettrico smarriti o distrutti per timore del contagio. Anche le catenine, i ciondoli, gli orecchini, l’orologio, le chiavi di casa, le carte di credito o solo la foto ingiallita dal tempo della famiglia mai più ritrovati nello tsunami della pandemia, che ha travolto l’Italia. Il danno collaterale del Covid-19, come in guerra, è la penosa ricerca dei familiari delle vittime degli effetti personali dei loro cari. Il ricordo tangibile di chi non c’è più e non hai neppure avuto la possibilità di tenere per mano negli ultimi attimi di vita.
“Il cellulare con le foto delle nipotine e quelle scattate assieme, il suo orologio che la famiglia gli ha regalato a gennaio per l’ultimo compleanno sono oggetti di grande valore affettivo per me. Le ultime cose che ha toccato prima di venire stroncato dal virus” spiega a Panorama, Lorella Micucci, da Iesi in provincia di Ancona. Il marito, Marcello, è morto il 19 marzo a 58 anni all’ospedale Carlo Urbani. La coppia era volontaria della Croce rossa. “Mi hanno chiamato dicendo che mio marito non ce l’ha fatta - racconta la signora - Gli oggetti personali avrebbero dovuto essere consegnati all’impresa funebre, ma non avevano nulla. Un infermiere ha visto una busta nera, ma poi non sapeva che fine avesse fatto”. Lorella non si da per vinta e un nipote che smanetta con il computer geolocalizza il cellulare. “Era stato gettato in un cassonetto dei rifiuti non speciali - spiega - L’azienda sanitaria mi ha promesso che sarebbe intervenuta per fermare lo smaltimento, ma eravamo ancora in emergenza Covid e nessuno poteva andare ad aprire i sacchi delle immondizie”. Sul cellulare buttato via c’erano pure i codici della banca. “Anche gli occhiali da vista, l’orologio, tutto perduto per incuria” si rammarica Lorella, membro del gruppo “Noi denunceremo”, che vuole trovare i responsabili delle mancate zone rosse nella zona di Bergamo e delle troppe morti nelle case di riposo.
Il caso di Iesi non è il solo come dimostra la decina di segnalazioni a Trieste, dove in gran parte gli effetti personali sono stati ritrovati e consegnati, anche se ci sono voluti mesi. “Mia suocera Franca è mancata per il virus. Dopo un ricovero per un leggero ictus è stata contagiata in ospedale. Nella sua stanza su cinque pazienti quattro sono decedute” racconta un triestino, che preferisce mantenere l’anonimato. “L’altra faccia della tragedia è che abbiamo atteso due mesi e mezzo per farci restituire la fede. Mio suocero, che ha fatto cremare il corpo voleva metterla sull’urna delle ceneri come ricordo” spiega la fonte di Panorama. “Solo dopo avere denunciato il fatto sulla stampa locale abbiamo ricevuto, qualche giorno dopo, la fede e gli orecchini - spiega - I vestiti e anche la borsetta erano stati distrutti per timore del contagio”.
L’azienda sanitaria di Trieste conferma “che i beni dei pazienti venivano insacchettati e messi in quarantena. All’inizio, non essendo note le caratteristiche di infettività residua del virus, la quarantena è stata molto lunga, dell\\\'ordine del mese. Successivamente è stato possibile ridurne i tempi prima della consegna”. L’uffico legale ha preso a cuore i casi problematici, ma per Valdemara Amolaro, 76 anni, ci sono poche speranze di tornare in possesso degli effetti personali del marito, uno dei primi deceduti per il virus nel capoluogo giuliano. “Non riesco a mettermi il cuore in pace. A parte le pantofole, il pigiama, le ultime cose che indossava, figlio e nipote volevano avere come ricordo almeno il rasoio elettrico di Vitoluciano” spiega la vedova. “La caposala mi aveva detto che i suoi oggetti erano stati chiusi in uno scatolone, ma c’era l’isolamento e non potevo andare in ospedale. Poi il reparto Covid è stato dismesso e sembra che la cooperativa pulendo tutto abbia buttato via anche lo scatolone con scritto “indumenti infetti”, che conteneva gli effetti personali non solo di mio marito” racconta la signora Amolaro.
Nell’emergenza provocata dalla pandemia gli oggetti dei pazienti erano l’ultimo dei problemi. E si temeva la trasmissione del virus. Il fotografo vicentino, Mauro Pozzer, ha documentato la “guerra” contro il nemico invisibile dentro l’ospedale San Bortolo di Vicenza con il toccante reportage “Nessuno si salva da solo”. Non dimenticherà mai “il sotterraneo delle malattie infettive dove ho visto una stanza ripostiglio piena di sacchetti di plastica nera contenenti gli effetti personali dei pazienti. Gli oggetti dei morti Covid, che dovevano essere bruciati”. Pozzer racconta a Panorama che “le fedi venivano messe in sacchetti anti contagio per la sanificazione e restituzione. Quello che le vittime avevano addosso a cominciare dai vestiti e talvolta foto e documenti andavano direttamente all’inceneritore per evitare il contagio”.
A Civitanova Marche l’infermiere e sindacalista del reparto di rianimazione, Marcello Evangelista, ha aiutato i parenti delle vittime a recuperare gli effetti personali dei loro cari. “Il primo obiettivo era salvare vite - racconta a Panorama - I contagiati arrivavano a ondate con vestiti e tutti gli effetti personali addosso. La prima cosa da fare era denudarli e smaltire gli indumenti nei rifiuti speciali”. Evangelista ammette che nell’emergenza “non potevamo pensare alla monetina, il piccolo ricordo, ma le fedi, il portafoglio, le catenine venivano infilati dentro le buste del materiale infetto per salvarli. Qualche effetto personale sarà andato perduto, ma tanti sono stati riconsegnati ai familiari”. L’infermiere con 25 anni di esperienza viene chiamato da una signora che ha perso il marito “sto cercando la carta d’identità, la patente, qualsiasi cosa mi faccia ricordare di lui”. Evangelista l’aiuta: \\\"Ho aperto la porta di uno stanzino e mi sono trovato di fronte a un mucchio di sacconi neri ognuno con il nome di un paziente. Un brivido mi ha percorso la schiena e sono crollato a terra, in ginocchio di fronte a quello che restava delle vittime del Covid”. L’infermiere è rimasto “immobile per qualche minuto cercando di immaginare la vita di una persona racchiusa in un sacco della spazzatura”. Segretario regionale Uil Fpl sa che “qualcosa è andato perso oppure ritrovato nei rifiuti o mescolato alla biancheria sporca, ma nessuno l’ha fatto apposta. I primi a chiedere scusa ai familiari siamo noi personale sanitario, anche se bisogna capire cosa significa l’arrivo di 3-4 pazienti assieme in condizioni drammatiche”.
In diverse parti d’Italia i familiari hanno scritto lettere accorate alla stampa come il portale d’informazione cittadellaspezia.com. “Sono la figlia di uomo che è entrato in ospedale il 6 di marzo per un motivo diverso da quello che lo ha portato alla morte nella giornata del 22 marzo, cioè questo maledetto virus” si legge in rete. La figlia ha chiesto gli oggetti del papà: “Ero sconvolta, quando sono riuscita a parlare con la caposala era troppo tardi: tutto smaltito”. E si domanda: “E’ giusto che gli effetti personali vengano smaltiti tutti? È già molto triste non riavere il cellulare, l\\\'orologio e altre cose, ma i documenti , le carte di credito, le chiavi di casa sono oggetti che possono servire a chi resta, per tutte quelle pratiche da fare dopo la morte di una persona cara”.
In alcuni casi, per fortuna, c’è il lieto fine. Il 14 luglio Donatella Pagani, sulla pagine Facebook di “Noi denunceremo” ha postato la foto di uno scintillante anello di nozze. E commentato con l’aggiunta di un cuoricino nero, segno di lutto: “Dopo più di 3 mesi e mezzo siamo riusciti a riavere la tua fede… è un’emozione grandissima… è come se una parte di te mamma fosse tornata a casa”. |
| [continua] |
|
video
|
|
|
05 aprile 2020 | Tg5 | reportage
Virus, il fronte che resiste in Friuli-Venezia Giulia
Fausto Biloslavo
TRIESTE - “Anche noi abbiamo paura. E’ un momento difficile per tutti, ma dobbiamo fare il nostro dovere con la maggiore dedizione possibile” spiega Demis Pizzolitto, veterano delle ambulanze del 118 nel capoluogo giuliano lanciate nella “guerra” contro il virus maledetto. La battaglia quotidiana inizia con la vestizione: tuta bianca, doppi guanti, visiera e mascherina per difendersi dal contagio. Il veterano è in coppia con Fabio Tripodi, una “recluta” arrivata da poco, ma subito spedita al fronte. Le due tute bianche si lanciano nella mischia armati di barella per i pazienti Covid. “Mi è rimasta impressa una signora anziana, positiva al virus, che abbiamo trasportato di notte - racconta l’infermiere Pizzolitto - In ambulanza mi ha raccontato del marito invalido rimasto a casa. E soffriva all’idea di averlo lasciato solo con la paura che nessuno si sarebbe occupato di lui”.
Bardati come due marziani spariscono nell’ospedale Maggiore di Trieste, dove sono ricoverati un centinaio di positivi, per trasferire un infetto che ha bisogno di maggiori cure. Quando tornano caricano dietro la barella e si chiudono dentro l’ambulanza con il paziente semi incosciente. Si vede solo il volto scavato che spunta dalle lenzuola bianche. Poi via a sirene spiegate verso l’ospedale di Cattinara, dove la terapia intensiva è l’ultima trincea per fermare il virus.
Il Friuli-Venezia Giulia è il fronte del Nord Est che resiste al virus grazie a restrizioni draconiane, anche se negli ultimi giorni la gente comincia ad uscire troppo di casa. Un decimo della popolazione rispetto alla Lombardia ha aiutato a evitare l’inferno di Bergamo e Brescia. Il 4 aprile i contagiati erano 1986, i decessi 145, le guarigioni 220 e 1103 persone si trovano in isolamento a casa. Anche in Friuli-Venezia Giulia, come in gran parte d’Italia, le protezioni individuali per chi combatte il virus non bastano mai. “Siamo messi molto male. Le stiamo centellinando. Più che con le mascherine abbiamo avuto grandi difficoltà con visiere, occhiali e tute” ammette Antonio Poggiana, direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trieste e Gorizia. Negli ultimi giorni sono arrivate nuove forniture, ma l’emergenza riguarda anche le residenze per anziani, flagellate dal virus. “Sono “bombe” virali innescate - spiega Alberto Peratoner responsabile del 118 - Muoiono molti più anziani di quelli certificati, anche 4-5 al giorno, ma non vengono fatti i tamponi”.
Nell’ospedale di Cattinara “la terapia intensiva è la prima linea di risposta contro il virus, il nemico invisibile che stiamo combattendo ogni giorno” spiega Umberto Lucangelo, direttore del dipartimento di emergenza. Borse sotto gli occhi vive in ospedale e da separato in casa con la moglie per evitare qualsiasi rischio. Nella trincea sanitaria l’emergenza si tocca con mano. Barbara si prepara con la tuta anti contagio che la copre dalla testa ai piedi. Un’altra infermiera chiude tutti i possibili spiragli delle cerniere con larghe strisce di cerotto, come nei film. Simile ad un “palombaro” le scrivono sulla schiena il nome e l’orario di ingresso con un pennarello nero. Poi Barbara procede in un’anticamera con una porta a vetri. E quando è completamente isolata allarga le braccia e si apre l’ingresso del campo di battaglia. Ventuno pazienti intubati lottano contro la morte grazie agli angeli in tuta bianca che non li mollano un secondo, giorno e notte. L’anziano con la chioma argento sembra solo addormentato se non fosse per l’infinità di cannule infilate nel corpo, sensori e macchinari che pulsano attorno. Una signora è coperta da un telo blu e come tutti i pazienti critici ripresa dalle telecamere a circuito chiuso.
Mara, occhioni neri, visiera e mascherina spunta da dietro la vetrata protettiva con uno sguardo di speranza. All’interfono racconta l’emozione “del primo ragazzo che sono riuscito a svegliare. Quando mi ha visto ha alzato entrambi i pollici in segno di ok”. E se qualcuno non ce la fa Mara spiega “che siamo preparati ad accompagnare le persone verso la morte nella maniera più dignitosa. Io le tengo per mano per non lasciarle sole fino all’ultimo momento”.
Erica Venier, la capo turno, vuole ringraziare “con tutto il cuore” i triestini che ogni giorno fanno arrivare dolci, frutta, generi di conforto ai combattenti della terapia intensiva. Graziano Di Gregorio, infermiere del turno mattutino, è un veterano: “Dopo 22 anni di esperienza non avrei mai pensato di trovarmi in una trincea del genere”. Il fiore all’occhiello della rianimazione di Cattinara è di non aver perso un solo paziente, ma Di Gregorio racconta: “Infermieri di altre terapie intensive hanno dovuto dare l’estrema unzione perchè i pazienti sono soli e non si può fare diversamente”.
L’azienda sanitaria sta acquistando una trentina di tablet per cercare di mantenere un contatto con i familiari e permettere l’estremo saluto. Prima di venire intubati, l’ultima spiaggia, i contagiati che hanno difficoltà a respirare sono aiutati con maschere o caschi in un altro reparto. Il direttore, Marco Confalonieri, racconta: “Mio nonno era un ragazzo del ’99, che ha combattuto sul Piave durante il primo conflitto mondiale. Ho lanciato nella mischia 13 giovani appena assunti. Sono i ragazzi del ’99 di questa guerra”.
|
|
|
|
|
10 giugno 2008 | Emittente privata TCA | reportage
Gli occhi della guerra.... a Bolzano /2
Negli anni 80 lo portava in giro per Milano sulla sua 500, scrive Panorama. Adesso, da ministro della Difesa, Ignazio La Russa ha voluto visitare a Bolzano la mostra fotografica Gli occhi della guerra, dedicata alla sua memoria. Almerigo Grilz, triestino, ex dirigente missino, fu il primo giornalista italiano ucciso dopo la Seconda guerra mondiale, mentre filmava uno scontro fra ribelli e governativi in Mozambico nell’87. La mostra, organizzata dal 4° Reggimento alpini paracadutisti, espone anche i reportage di altri due giornalisti triestini: Gian Micalessin e Fausto Biloslavo.
|
|
|
|
|
14 maggio 2020 | Tg5 | reportage
Trieste, Lampedusa del Nord Est
Fausto Biloslavo
TRIESTE - Il gruppetto è seduto sul bordo della strada asfaltata. Tutti maschi dai vent’anni in su, laceri, sporchi e inzuppati di pioggia sembrano sfiniti, ma chiedono subito “dov’è Trieste?”. Un chilometro più indietro passa il confine con la Slovenia. I migranti illegali sono appena arrivati, dopo giorni di marcia lungo la rotta balcanica. Non sembra il Carso triestino, ma la Bosnia nord occidentale da dove partono per arrivare a piedi in Italia. Scarpe di ginnastica, tute e qualche piumino non hanno neanche uno zainetto. Il più giovane è il capetto della decina di afghani, che abbiamo intercettato prima della polizia. Uno indossa una divisa mimetica probabilmente bosniaca, un altro ha un barbone e sguardo da talebano e la principale preoccupazione è “di non venire deportati” ovvero rimandati indietro. Non sanno che la Slovenia, causa virus, ha sospeso i respingimenti dall’Italia. Di nuovo in marcia i migranti tirano un sospiro di sollievo quando vedono un cartello stradale che indica Trieste. Il capetto alza la mano in segno di vittoria urlando da dove viene: “Afghanistan, Baghlan”, una provincia a nord di Kabul.
Il 12 maggio sono arrivati in 160 in poche ore, in gran parte afghani e pachistani, il picco giornaliero dall’inizio dell’anno. La riapertura della rotta balcanica sul fronte del Nord Est è iniziata a fine aprile, in vista della fase 2 dell’emergenza virus. A Trieste sono stati rintracciati una media di 40 migranti al giorno. In Bosnia sarebbero in 7500 pronti a partire verso l’Italia.
Il gruppetto di afghani viene preso in carico dai militari del reggimento Piemonte Cavalleria schierato sul confine con un centinaio di uomini per l’emergenza virus. Più avanti sullo stradone di ingresso in città, da dove si vede il capoluogo giuliano, la polizia sta intercettando altri migranti. Le volanti con il lampeggiante acceso “scortano” la colonna che si sta ingrossando con decine di giovani stanchi e affamati. Grazie ad un altoparlante viene spiegato in inglese di stare calmi e dirigersi verso il punto di raccolta sul ciglio della strada in attesa degli autobus per portarli via. Gli agenti con le mascherine controllano per prima cosa con i termometri a distanza la temperatura dei clandestini. Poi li perquisiscono uno ad uno e alla fine distribuiscono le mascherine ai migranti. Alla fine li fanno salire sugli autobus dell’azienda comunale dei trasporti cercando di non riempirli troppo per evitare focolai di contagio. “No virus, no virus” sostiene Rahibullah Sadiqi alzando i pollici verso l’alto in segno di vittoria. L’afghano è partito un anno fa dal suo paese e ha camminato per “dodici giorni dalla Bosnia, attraverso la Croazia e la Slovenia fino all’Italia”. Seduto per terra si è levato le scarpe e mostra i piedi doloranti. “I croati mi hanno rimandato indietro nove volte, ma adesso non c’era polizia e siamo passati tutti” spiega sorridendo dopo aver concluso “il gioco”, come i clandestini chiamano l’ultimo tratto della rotta balcanica.
“Abbiamo registrato un crollo degli arrivi in marzo e per gran parte di aprile. Poi un’impennata alla fine dello scorso mese fino a metà maggio. L’impressione è che per i paesi della rotta balcanica nello stesso periodo sia avvenuta la fine del lockdown migratorio. In pratica hanno aperto i rubinetti per scaricare il peso dei flussi sull’Italia e sul Friuli-Venezia Giulia in particolare creando una situazione ingestibile anche dal punto di vista sanitario. E’ inaccettabile” spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che punta il dito contro la Slovenia.
Lorenzo Tamaro, responsabile provinciale del Sindacato autonomo di polizia, denuncia “la carenza d’organico davanti all’emergenza dell’arrivo in massa di immigrati clandestini. Rinnoviamo l’appello per l’invio di uomini in rinforzo alla Polizia di frontiera”.
In aprile circa il 30% dei migranti che stazionavano in Serbia è entrato in Bosnia grazie alla crisi pandemica, che ha distolto uomini ed energie dal controllo dei confini. Nella Bosnia occidentale non ci sono più i campi di raccolta, ma i migranti bivaccano nei boschi e passano più facilmente in Croazia dove la polizia ha dovuto gestire l’emergenza virus e pure un terremoto.
Sul Carso anche l’esercito impegnato nell’operazione Strade sicure fa il possibile per tamponare l’arrivo dei migranti intercettai pure con i droni. A Fernetti sul valico con la Slovenia hanno montato un grosso tendone mimetico dove vengono portati i nuovi arrivati per i controlli sanitari. Il personale del 118 entra con le protezioni anti virus proprio per controllare che nessuno mostri i sintomi, come febbre e tosse, di un possibile contagio. Il Sap è preoccupato per l’emergenza sanitaria: “Non abbiamo strutture idonee ad accogliere un numero così elevato di persone. Servono più ambienti per poter isolare “casi sospetti” e non mettere a rischio contagio gli operatori di Polizia. Non siamo nemmeno adeguatamente muniti di mezzi per il trasporto dei migranti con le separazioni previste dall’emergenza virus”.
Gli agenti impegnati sul terreno non sono autorizzati a parlare, ma a denti stretti ammettono: “Se va avanti così, in vista della bella stagione, la rotta balcanica rischia di esplodere. Saremo travolti dai migranti”. E Trieste potrebbe trasformarsi nella Lampedusa del Nord Est.
|
|
|
|
radio

|
27 gennaio 2020 | Radio 1 Italia sotto inchiesta | intervento |
Italia
Esercito e siti ebraici
Fausto Biloslavo
I nostri soldati rispettano la giornata della Memoria dell’Olocausto non solo il 27 gennaio, ma tutto l’anno. L’esercito, con l’operazione Strade sicure, schiera 24 ore al giorno ben 700 uomini in difesa di 58 siti ebraici sul territorio nazionale. Tutti obiettivi sensibili per possibile attentati oppure oltraggi anti semiti.
“Per ora non è mai accaduto nulla anche grazie alla presenza dei militari, che serve da deterrenza e non solo. Il senso di sicurezza ha evitato episodi di odio e minacce ripetute come in Francia, che rischiano di provocare un esodo della comunità ebraica” spiega una fonte militare de il Giornale.
I soldati, che si sono fatti le ossa all’estero, sorvegliano, quasi sempre con presidi fissi, 32 sinagoghe o tempi ebraici, 9 scuole, 4 musei e altri 13 siti distribuiti in tutta Italia, ma soprattutto al nord e al centro. La città con il più alto numero di obiettivi sensibili, il 41%, è Milano. Non a caso il comandante del raggruppamento di Strade sicure, come in altre città, è ufficialmente invitato alle celebrazioni del 27 gennaio, giorno della Memoria.
Lo scorso anno, in occasione dell’anniversario della nascita dello Stato di Israele, il rappresentante della comunità ebraica di Livorno, Vittorio Mosseri, ha consegnato una targa al comandante dei paracadustisti. “Alla brigata Folgore con stima e gratitudine per il servizio di sicurezza prestato nell’ambito dell’operazione Strade sicure contribuendo con attenzione e professionalità al sereno svolgimento delle attività della nostro comunità” il testo inciso sulla targa.
In questi tempi di spauracchi anti semiti l’esercito difende i siti ebraici in Italia con un numero di uomini praticamente equivalente a quello dispiegato in Afghanistan nel fortino di Herat. Grazie ad un’esperienza acquisita all’estero nella protezione delle minoranze religiose, come l’antico monastero serbo ortodosso di Decani in Kosovo.
“In ogni città dove è presente la comunità ebraica esiste un responsabile della sicurezza, un professionista che collabora con le forze dell’ordine ed i militari per coordinare al meglio la vigilanza” spiega la fonte del Giornale. Una specie di “assessore” alla sicurezza, che organizza anche il sistema di sorveglianza elettronica con telecamere e sistemi anti intrusione di avanguardia su ogni sito. Non solo: se in zona appare un simbolo o una scritta anti semita, soprattuto in arabo, viene subito segnalata, fotografata, analizzata e tradotta. “I livelli di allerta talvolta si innalzano in base alla situazione internazionale” osserva la fonte militare. L’ultimo allarme ha riguardato i venti di guerra fra Iran e Stati Uniti in seguito all’eliminazione del generale Qassem Soleimani.
Roma è la seconda città per siti ebraici presidiati dai militari compresi asili, scuole e oratori. Le sinagoghe sono sorvegliate pure a Napoli, Verona, Trieste e quando necessario vengono disposte le barriere di cemento per evitare attacchi con mezzi minati o utilizzati come arieti. A Venezia i soldati garantiscono la sicurezza dello storico ghetto. A Livorno e in altre città sono controllati anche i cimiteri ebraici. Una residenza per anziani legata alla comunità è pure nella lista dei siti protetti a Milano. Ed i militari di Strade sicure nel capoluogo lombardo non perdono d’occhio il memoriale della Shoah, lo sterminio degli ebrei voluto da Hitler.
|
|
|
|
|