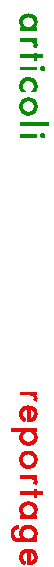
|
Reportage
15 gennaio 2011 - Esteri - Caucaso - Il Foglio |
|
| Blues caucasico |
“I cecchini sparano quasi ogni giorno. Gli azeri alzano dei manichini dalle loro trincee per provocare la nostra reazione. Poi ci individuano e cominciano a colpire. Così è stato ferito alla spalla Mher, un mio amico. E’ caduto a terra e gridava, mentre lo scontro a fuoco andava avanti per mezz’ora”. Artem Grigoryan, armeno di ventitré anni, magro e vestito di nero, racconta così la guerra più dimenticata del Caucaso meridionale. Nel 2008 si è arruolato volontario nell’esercito del Nagorno Karabakh, un’enclave sul territorio dell’Azerbaigian, che si proclama Repubblica. E’ un puntino sulla carta con meno di 150 mila
abitanti, che nessun paese riconosce. Tutto è cominciato nel 1992, quando i cristiani armeni e i musulmani azeri si sono scontrati per il controllo della regione. Dopo una mattanza di trentamila morti, centomila feriti e fiumi di profughi, gli armeni hanno avuto la meglio sugli azeri. I risulta ti si vedono ancora oggi, a pochi chilometri da Stepanakert, la capitale del Nagorno. Non c’è una casa in piedi, ma soltanto scheletri di pietra e cemento travolti dalla furia della guerra, ormai ricoperti dalle erbacce. Un tempo, Stepanekert era una roccaforte azera e si chiamava Agdam. Oggi ha cambiato nome rimanendo un cumulo di macerie. Qui è vietato persino fotografare. Settecentomila azeri sono fuggiti dal Nagorno Karabakh, e molti armeni erano stati espulsi ancora prima dall’Azerbaigian. Dal 1994, i due eserciti si fronteggiano sulla linea di contatto, una fila di bunker, trincee e postazioni fortificate lunga duecento chilometri, che assomiglia agli scenari della Prima guerra mondiale sul Carso. Per il presidente azero, Ilham Aliyev, della dinastia al potere sin dal crollo dell’Unione sovietica, è stata “una guerra di occupazione di un quinto del nostro territorio, durante la quale è stata perpetrata la pulizia etnica”.
Ashot Ghoulian, completo grigio impeccabile e occhi azzurri, è il presidente del Parlamento del Nagorno Karabakh e la pensa diametralmente all’opposto. “Per noi è una lotta per la sopravvivenza. Senza la nostra Repubblica rischiamo l’estinzione”, spiega al Foglio nel suo ufficio di Stepanakert, all’ombra dell’aquila che guarda verso ovest, il simbolo della patria armena. Il conflitto è congelato, ma negli ultimi mesi le violazioni della tregua sono aumentate. Ci sono tiri dei cecchini, dicono le autorità di Stepanakert, ma anche infiltrazioni di commando azeri che riusciono a entrare nelle trincee armene. L’ultimo soldato morto su questo fronte, tuttavia, è un azero, ucciso negli ultimi giorni del 2010. Da giugno hanno perso la vita una ventina di militari e sono 710 le violazioni lungo la linea di contatto denunciate all’Onu. Aliyev, ricostruisce il proprio esercito, aumenta le spese militari (3,12 miliardi di dollari) e sostiene che “una guerra nel Caucaso meridionale sarà inevitabile se gli armeni non se ne andranno”. A giugno ha ordinato esercitazioni che avevano come obiettivo “la liberazione delle nostre terre dagli occupanti”.
Ad Armagon, com’è chiamato il mastodontico ministero della Difesa di Yerevan, capitale dell’Armenia, gli annunci sono sempre presi sul serio. Senza l’appoggio armeno, i ventimila uomini che difendono l’enclave avrebbero poche speranze di sopravvivere a un’offensiva azera. “I loro sabotaggi sono simili ad una tattica suicida per testare la nostra reazione e magari provocare un’escalation – raccontano le fonti militari del Foglio a Yerevan – Se scateneranno una guerra, li attaccheremo dietro le linee colpendo i loro obiettivi sensibili”. Cominciando dalle installazioni petrolifere. A Stepanakert sono ancora più duri: “Se vogliono la guerra coinvolgerà tutto il Caucaso”, sostiene il presidente del Parlamento locale. La Turchia è la sorella maggiore dell’Azerbaigian, ma i russi hanno cinquemila soldati sul territorio armeno, nella base di Gyumri. Batterie di missili S300 difendono il paese, compresa la sua unica – e vetusta – centrale nucleare. L’Iran sta nel mezzo, ma teme l’influenza degli americani sui contendenti. La Cia spia il regime degli ayatollah e arruola studenti e commercianti sia in Armenia, sia in Azerbaigian.
Anche il Nagorno Karabakh, nei mesi scorsi, ha organizzato esercitazioni che prevedevano un attacco azero, la ritirata tattica e la controffensiva finale. I micidiali elicotteri d’attacco russi Hind Mi 24 sono arrivati dal cielo in appoggio a colonne di carri armati che avanzavano seguiti da fanteria e corpi speciali. Il fumo si è alzato sugli obiettivi azeri davanti al compiaciuto Serzh Sarkisian, presidente dell’Armenia, che assisteva al war game armato di binocolo. Poco prima aveva consegnato appartamenti nuovi agli ufficiali del posto, che piantonano la seconda linea difensiva. I beneficiari hanno ritirato le chiavi marciando alla vecchia maniera sovietica, stile mezzo passo dell’oca.
Sul terreno, però, la guerra vera è un fantasma. I militari del Nagorno Karabakh non permettono ai giornalisti di andare in prima linea, parlare con le unità al fronte è un’impresa. Le autorità gridano al pericolo imminente, ma non mostrano mai la decantata minaccia azera. Un seccato portavoce della Difesa locale sbotta: “I nostri uomini non parlano, ma combattono”. Per fortuna, i soldati che raccontano la vita in trincea si trovano. “Se alzi la testa di pochi centimetri ti sparano. Le trincee sono talmente vicine, anche a 150 metri, che spesso ci urliamo insulti con gli azeri – racconta Andrey Grigoryan, 21 anni – Si dorme in dieci nei bunker sotterranei e il turno in prima linea dura una settimana. Quando cade la neve è dura e si arriva a venti gradi sotto zero”. Il servizio militare è obbligatorio a cominciare dai 18 anni. Quasi tutti hanno i flash della terribile guerra del 1992, quando vivevano con le famiglie negli scantinati a causa dei bombardamenti.
Tutti si rendono conto che “la guerra non è finita” e giurano di essere “pronti a morire per la patria e per difendere la famiglia”. Ma sperano che prima o dopo il Nagorno Karabakh sia riconosciuto e arrivino truppe di pace. I giovani vogliono viaggiare, ma con 120 mila dram al mese (circa 240 euro) è dura “visitare l’Italia, farmi una famiglia e comprare una macchina”, spiega un giovane di nome Armen in un giardino pubblico di Stepanakert.
Il mito di questa generazione è Ashot Danielyan, lo sportivo del Nagorno Karabakh che, agli inizi di novembre, è diventato campione mondiale di sambo, un’arte marziale russa. Alle esercitazioni militari hanno assistito anche due religiosi armeni in tonaca lunga e nera.
Padre Grigor, 54 anni, barba e capelli color argento, è uno dei preti combattenti che imbracciò il fucile nella guerra del ’92. E che sarebbe pronto a rifarlo. Nel monastero di Ganzasar, che vuol dire “montagna del tesoro”, recita la messa avvolto da una nuvola di incenso in un’atmosfera di altri tempi. Sulle mura esterne ci sono ancora i segni dei proiettili e delle schegge. “Il vescovo mi ha benedetto e consegnato un fucile – ricorda il prete combattente – Non dimenticherò mai le sue parole. Non c’è arma più grande della croce, ma questa guerra dobbiamo vincerla e abbiamo bisogno sia della croce, sia del fucile”. Prima faceva il violinista, ma nel violento disfacimento del
Caucaso ha trovato la fede e la patria nel Nagorno Karabakh, trasformandosi in una specie di crociato. Sui massacri compiuti dagli armeni, come quello di Khojaly, il villaggio nel quale furono massacrate 613 persone, comprese 106 donne e 83 bambini, avanza seri dubbi e incolpa gli azeri (“noi lasciavamo sempre un canale umanitario aperto”). Con le dita sfiora la grande croce che porta al collo e dice di non pentirsi di nulla: “La guerra potrebbe ricominciare, ma chi attaccherà per primo verrà sconfitto – racconta – Se gli azeri lo facessero, forse un giorno arriveremo a Baku. Sono pronto a tornare in prima linea con la croce e il fucile”. Sotto il monastero di padre Grigor si allarga il villaggio di Vanq, conosciuta come la seconda capitale del Karabakh.
In ottobre, Levon Hairabedian, un uomo d’affari armeno diventato ricco all’estero, ha invitato Albano Carrisi a inaugurare il nuovo e scintillante asilo locale, che si chiama “Farfalla”.
Il cantante italiano, molto amato nei paesi che facevano parte dell’Unione sovietica, aveva appena tenuto un concerto a Yerevan e si è esibito anche nello sperduto villaggio del Nagorno Karabakh. Gli azeri si sono infuriati, e il governo di Baku ha minacciato di inserire Albano nella lista delle persone non grate. Uno dei problemi più gravi del conflitto fantasma è la questione dei profughi. Davanti all’Assemblea generale dell’Onu, il presidente azero ha ricordato che “una persona ogni nove nel mio paese è un profugo o rifugiato”. Circa settecentomila azeri fuggirono dal Nagorno Karabakh e dall’Armenia durante la guerra del ’92. Prima, però, 250 mila armeni sono stati costretti a lasciare Baku e dintorni perdendo tutto. Mikael Hajiyan è il portavoce del Parlamento di Stepanakert. “Sono nato a Ghiurgevan, in Azerbaigian, che nel 1918 fu rasa al suolo da turchi e azeri. I sovietici ricostruirono tutto, a parte la chiesa. Usarono quello che ne restava per edificare una scuola”, racconta il baffuto giornalista. Nel 1988 gli azeri lo deportarono con tutta la sua comunità: fu allora, dice, che scoprì la fede. “Mi sono fatto battezzare a 46 anni a Stepanakert, con la mia famiglia – racconta Hajiyan – E’ stato un ritorno alle origini che mi ha permesso di riscoprire un valore fondante dell’identità nazionale armena”. Adesso dirige una radio, che trasmette anche in azero, per parlare dei pogrom della sua comunità. L’attaccamento degli armeni a queste terre, che chiamano con il nome storico di Artsakh, è simboleggiato dalle statue stilizzate di un uomo e una donna. Due grandi figure che affondano il corpo proprio nella terra, non molto lontano del nuovo aeroporto di Stepanakert. Entro gennaio, quando la struttura sarà operativa, il Nagorno Karabakh sarà meno isolato. “Ma la situazione sul terreno è tesa, difficile e foriera di eventuali rischi”, ammette Raul de Luzenberger, il rappresentante dell’Unione europea a Yerevan. Nonostante il nome, è un napoletano che si è fatto le ossa nelle crisi più ostiche del mondo post sovietico. Cravatta rossa a pallini e gessato, parla russo e ricorda con piacere le proprie origini austriache, le influenze fiumane e la lunga storia della famiglia a Gorizia, prima che il bisnonno sposasse una borbonica (nel 1918, lui sventolò il tricolore fuori dalla finestra per la vittoria della Prima guerra mondiale, e lei lo gelò con un sibillino “leva ‘sta pezza”). Questo miscuglio familiare aiuta il diplomatico nel Caucaso, un intreccio che potrebbe creare enormi problemi ai nostri rifornimenti energetici.
A Baku, Yerevan e Stepanakert aspettavano il summit dell’Osce che si è svolto ad Astana i primi due giorni di dicembre, ma l’incontro fra i rappresentanti dei governi e i mediatori internazionali non ha fornito grandi prospettive. Nella capitale armena e a Bruxelles c’è una lobby che lavora per evitare il peggio e avvicinare il paese all’Unione europea. Tutti giovani, poco più che trentenni, che parlano perfettamente l’italiano. Quando erano adolescenti e il Caucaso ribolliva nella disgregazione sovietica sono stati mandati a studiare al sicuro, nell’antico collegio armeno di Venezia. Qualcuno fa l’imprenditore, come Achot Chakhmouradian. “Dobbiamo aprire le frontiere con la Turchia. Per fare arrivare i macchinari della Fiat sono costretto a pagare più dazi passando dalla Georgia – spiega l’uomo, che si è laureato alla Bocconi – Il pericolo di guerra esiste, ma la gente non ha più voglia di morire. L’Armenia deve andare verso l’Europa senza dimenticare la Russia”.
“Ci chiamano gli italiani dell’Armenia perchè il vostro paese è rimasto nel nostro cuore”, spiega Mikayel Minasyan, detto Misha, erede di una famiglia che contava anche ai tempi del Politburo. Oggi è il vicecapo della squadra del presidente (nonché suo genero), ha una laurea in Scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di Gorizia ed è tornato in Armenia con l’obiettivo “di lavorare per il futuro del paese”. Al collegio di Venezia era compagno di banco di Sargis Ghazaryan, che lavora a Bruxelles con l’organizzazione non governativa “Amici europei dell’Armenia”. Barbetta e occhiali da intellettuale, dice che il suo compito “è creare e rafforzare i ponti fra l’Armenia e l’Europa: ho imparato a Gorizia, una volta divisa in due dalla frontiera di ferro con la Yugoslavia, che le cicatrici della storia si possono rimarginare. Forse capiterà anche a noi armeni un giorno, con i turchi e gli azeri”. |
| |
|
|
|
|