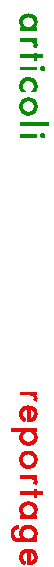
|
Reportage
08 aprile 2012 - Album - Bosnia Erzegovina - Il Giornale |
|
| A Sarajevo la guerra etnica cova ancora sotto le ceneri |
Rosse come il sangue. In fila come lapidi. Lunghe, sterminate, infinite. Come i giorni dell’assedio, della guerra, della paura. 11541 sedie senza un’anima. Tante quante i morti. Le sedie vuote di Sarajevo. 650 basse, minuscole. Come i corpi dei loro bambini Una sciabolata vermiglia tra la cittadella turca di Basharska e Marshala Tita. 11541 anime trascinate via dal vento di follia che spazzò la Jugoslavia, scese su Sarajevo il 6 aprile 1992, congelò la città per tre anni. I sopravvissuti le guardano. Lydia ha i capelli grigi. Per lei i nomi del tabellone non sono lettere. Sono volti nella memoria lacrime sulle gote. Per chi ha meno di dieci anni sono favole sussurrate da papà, occhi spalancati su quella rossa distesa di tristezza. Per noi, estranei ritornati vent’anni dopo, sono la paura di quei giorni, l’angoscia di una città dove non sapevi mai se arrivavi al giorno dopo.
Inizia tutto una sera. L’Holiday Inn è ancora scintillio di luci, la guerra un fantasma alle porte. Alija Izetbegovic, leader dei bosgnacchi musulmani, Radovan Karadzic per i serbi e il croato Mate Boban sono tutti lì in smoking e farfallino. È l’ultima festa prima del referendum per l’indipendenza della Bosnia Erzegovina, l’ultima sera prima del grande balzo verso guerra e morte. Si concedono ai giornalisti, ma sono già nemici. Senza più sguardi. Senza più parole. È l’inizio della fine e loro già interpretano lo scontro surreale, il trionfo dell’ideologia, dell’odio sulla ragione. La pentola a pressione del socialismo targato Maresciallo Tito è già saltata. La storia riscritta nel nome dello scontro etnico bussa alle porte, diventa spietato folklore. Ha il volto dei miliziani croati incontrati quand’è già guerra alle porte della città. Hanno chiome scolpite ad U nel nome dei progenitori Ustascia di Ante Pavelic, alleato del Terzo Reich. Vive nell’immagine di un anziano miliziano serbo con in pugno un moschetto d’altri tempi e in testa la bustina dei Karadjordjevic, i monarchi jugoslavi. Per lui la guerra è quella dei miliziani cetnici fedeli alla monarchia. E riemergono - in quei giorni cupi - anche i simboli dei reparti islamici fedeli, 40 anni prima, al terzo Reich. Il ritorno al passato, il salto nella guerra si consuma con il rogo della biblioteca centrata dalle bombe serbe, cancellata con i suoi libri. Oggi vent’anni dopo è l’ultima rovina da ricostruire. Tutt’intorno la città imbelletta le sue cicatrici. Dalle rovine del quotidiano Oslobodenje , simbolo dell’assedio è sorto l’hotel Plaza. Le torri gemelle del centro tiro a segno per cecchini e granate, sono di nuovo scintillanti. Il tunnel della vita, scavato sotto l’aeroporto per evacuare feriti, portare cibo e munizioni è nei giorni d’assedio un angusto cunicolo di 860 metri squassato dal rimbombo delle esplosioni tra le rovine del quartiere di Hrasniza. Oggi è un museo, dove si paga anche per posteggiare.
Solo la biblioteca attende, nuda come uno scheletro vuoto. Rinascerà, ma non ha più i suoi libri e diventerà municipio. Per ora resta scheletro vuoto. Come le anime sopravvissute alla guerra, ma bruciate dal suo fuoco. Come Jana. È maggio 1992. Ivo Standeker collega sloveno e Jana Schneider fotografa americana sono già nella città assediata. Al telefono Ivo spiega come passare i posti di blocco. «Portate candele qui non c’è luce » sussurra. Il giorno dopo è già cadavere, dilaniato da una granata di carro armato. Il suo corpo è all’ospedale serbo di Ilidja. In corsia c’è Jana viva, ma imbottita di schegge. La carichiamo in macchina, la riportiamo a Sarajevo. Il fuoco dei cecchini è ticchettio leggero sull’asfalto. Terrore costante nell’abitacolo.«A 120 a 120-strilla lei- oltre questa velocità non ti colpiscono ».La lasciamo all’ospedale, ma la nebbia di quei giorni non lascia più la sua mente.
Non ci sono alberghi. Non ci sono rifugi. Il nostro primo letto a Sarajevo è il pavimento di un appartamento al quinto piano di un palazzone socialista del quartiere di Bistrik. Dejan Bogigevic, giornalista di Radio Sarajevo, ogni notte si alza, striscia nel buio, tenta disperato di chiamare la moglie Lala e le figlie Idissa e Rajna spedite in Austria all’inizio della guerra. A distrarlo sono solo le bombe. Quando le schegge piovono sulla facciata, abbandona la cornetta ci spinge in cantina. Una mattina un mortaio centra un balcone. Davanti ai nostri occhi sfila un troncone insanguinato caricato in un bagagliaio davanti agli occhi di donne senza più lacrime.
La sopravvivenza è un’arte. Le case di Dejan e delle altre anime morte di Sarajevo sono veri rifugi. Acqua nel bagnetto di plastica delle bambine. Acqua nelle bottiglie. Acqua in taniche e catini. Per trovarla si scende al fiume, ma si rischia di pagarla con la vita perché i cecchini ti aspettano al varco come avvoltoi.
Le stanze esposte verso le montagne, sono la «zona della morte». Da lì scendono papà Arif Bunguri e il figlio Miky di 7 anni. Una granata li ha trasformati in maschere di sangue e sofferenza. Nel pronto soccorso del quartiere il dottor Alja Celo affonda le pinze, estrae le schegge, mentre Miky s’ingozza di dolore e lacrime. Noi filmiamo. Oggi, 20 anni dopo, Miky ha 27 anni. Ci guarda stupito, frastornato mentre le immagini di allora risvegliano il dolore addormentato. Guarda il padre. Loro si sono salvati, ma 11541 no.
Fra questi ci sono anche dei serbi che vivevano a Sarajevo in 170mila. Venti anni dopo sono solo 15mila, soprattutto anziani che non sanno dove andare. Branko Mandic faceva l’interprete per i giornalisti sul fronte serbo. Oggi è assistente del ministro degli Esteri dopo aver servito come ambasciatore della nuova Bosnia in Ungheria. A Sarajevo, dove viveva prima della guerra, ci va solo per lavorare e alla sera torna a Pale l’ex quartier generale di Radovan Karadzic e Ratko Mladic, accusati di genocidio, sulle colline che sovrastano la capitale. Per i serbi la lunga scia di sedie rosse che ricorda l’assedio è una «provocazione». Mandic non ha dubbi: «La gente ha perso tutto e guadagnato poco con la guerra, ma se la comunità internazionale ci lascia andare avanti da soli si ricomincia a sparare il giorno dopo». |
| [continua] |
|
video
|
|
|
07 settembre 2020 | Quarta Repubblica | reportage
Con i migranti illegali della rotta balcanica
I migranti pachistani della rotta balcanica attraversano di corsa il confine fra Bosnia e Croazia.
Dal tappo bosniaco 8mila migranti vogliono partire verso l’Italia. E oltre 4mila sono arrivati in Friuli-Venezia Giulia dall’inizio dell’anno.
I migranti chiamano the game, il gioco, il tragitto clandestino fino all’Italia, ma c’è chi prova dieci o venti volte prima di riuscire a passare.
I croati usano droni, camere termiche e non trattano i migranti con i guanti, che vivono in condizioni estreme.
Nel cantone di Bihac la situazione è esplosiva. La popolazione vuole la chiusura dei campi di accoglienza. A Bihac i cooperanti italiani aiutano i migranti.
Centinaia di migranti sono intrappolati nella terra di nessuno fra la zona serba e musulmana della Bosnia. Nessuno li vuole e li spinge da una parte e dall’altra.Così scoppiano scontri con i migranti che gridano Allah o akbar, dio è grande, sfidando la polizia.
Per arrivare in Italia usano una app che indica la posizione anche senza internet.In molti vivono in edifici fatiscenti.
Nei campi ufficiali non mancano le rivolte. E se verranno chiusi sarà ancora peggio.
Questi marocchini appena respinti dai croati ci proveranno ancora come gli altri 8mila migranti.
|
|
|
|
|
|
|
|