LIBRO E MOSTRA Gli occhi
della guerra
|
Gli occhi della guerra incrociati in tanti reportage in prima linea. Per questo gli occhi della guerra diventano il titolo di un libro fotografico. Un libro per raccontare, con immagini e sguardi fugaci, 25 anni di servizi dai fronti più caldi del mondo.
|
| [continua] |
REPORTAGE
Taiwan
In attesa
del peggio
|
| TAIPEI - Le urla strazianti sembrano vere. I corpi distesi a terra, sedie e tavoli ribaltati, sirene d’allarme e gente presa dal panico rendono l’idea di cosa potrebbe accadere se i missili di Pechino piombassero su Taiwan, l’isola libera dell’estremo Oriente che la Cina considera roba sua. L’esercitazione di primo soccorso è organizzata dall’Accademia Kuma, che usa come stemma l’Orso nero, simbolo nazionale, con un fucile a tracolla. |
| [continua] |
|
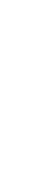
|
I libri degli altri
 Lezioni di giornalismo Lezioni di giornalismo
 |
autore: Virginia Di Marco
editore: Mursia
anno: 2015
pagine: 280
|
Di questo, e di tante altre cose, parliamo con uno dei principali inviati al fronte italiani, che è anche uno dei pochissimi freelance di successo: Fausto Biloslavo.
Come hai capito che volevi fare l’inviato?
Quando ancora portavo i calzoni corti – ero alle superiori, io ho fatto il nautico – avevo tre pulsioni: girare il mondo, ricercare un pizzico avventura e riuscire a farlo scrivendo e fotografando. Questo mi ha spinto ad andare a raccontare le guerre. Ho iniziato con due colleghi, anche loro giovanissimi e triestini come me: Gian Micalessin e Almerigo Grilz. Nel 1982 abbiamo seguito l’invasione israeliana del Libano. Io avevo 21 anni. L’anno dopo abbiamo fondato tutti e tre insieme la “Albatros Press Agency”, un’agenzia d’informazione di freelance puri. Ci autofinanziavamo i reportage, andavamo dove volevamo, dove pensavamo che ci fosse una storia da raccontare. Poi, al ritorno, la vendevamo. In Italia ancora oggi la parola freelance sembra una parolaccia: ma io ho iniziato così. E senza la tecnologia di oggi. Noi giravamo con Olivetti, rullini, Super 8.
Questo approccio è alla portata di tutti, economicamente parlando?
Quando abbiamo iniziato questa avventura, io ero studente all’università e facevo l’addetto alla sbarra in un campeggio di Grado. Gian Micalessin portava in giro carta igienica, Amerigo Grilz vendeva libri. Ovviamente eravamo un po’ folli: per esempio, andavamo in giro senza assicurazione. Però ci credevamo moltissimo: e questo stile “armiamoci e partiamo” è alla portata di tutti quelli che ci credono veramente, per cui questo mestiere non è solo un lavoro, ma una passione. Chiaramente, abbiamo messo sul tavolo tutto. Amerigo è morto in Monzambico nel 1987 e nello stesso anno io sono finito in galera in Afhganistan. Ecco perché l’inviato di guerra fatto in questa maniera garibaldina e avventurosa si può fare solo da giovani, giovanissimi: a cinquant’anni, con una famiglia, diventa più difficile.
Prima andavi in giro con l’Olivetti. E ora?
Oggi tutto va molto più veloce: e questo è un bene e un male. Per esempio, puoi essere battuto sul tempo dai telefonini dei ribelli che linciano Gheddafi. Alla morte del colonello libico non c’era nessun giornalista: il primo reporter che è arrivato è stato un fotografo che che ha scattato delle foto un po' insulse quando era tutto finito.
Io ho avuto la fortuna di vivere questa rivoluzione tecnologica copernicana per i giornalisti di guerra. Durante l’invasione dell’Iraq ero al seguito – ma non embedded – delle truppe alleate; ogni sera mi piazzavo sul tetto della mia gip, tiravo fuori un satellitare, lo collegavo al computer portatile con cui scrivevo i pezzi e inviavo articolo e foto in tempo reale alla redazione. Una cosa impensabile negli anni Ottanta, quando ho iniziato. Le nuove tecnologie non ha cambiato radicalmente solo il lato di comunicazione delle notizie (vale a dire i tempi di trasmissione). Pensiamo al passaggio dalla Reflex con antico rullino alla macchinetta digitale. Prima tu scattavi, ma non sapevi cosa avevi fotografato fino a quando non sviluppavi le foto. Con la digitale, invece, scatti e controlli: puoi cancellare, migliorare, spedire.
La rivoluzione, oltre che copernicana, è continua: ti consente, per esempio, di fare con un modem satellitare e una telecamera dirette via streaming anche se non disponi di grandi strutture da network americani o arabi. Io sono riuscito a trasmettere in diretta persino dalla portaerei Garibaldi, nel Golfo della Sirte, vale a dire in mezzo al nulla. Un altro strumento d’informazione formidabile è Twitter, seppure ancora poco usato dagli italiani.
Per trovare le notizie sono fondamentali i contatti giusti. Come ti regoli la prima volta che sei in un posto?
I contatti non si creano da soli, e neanche i reportage di guerra. Io dico sempre che la preparazione deve essere continua. Tu non puoi andare in Libia o coprire la primavera araba se prima non hai approfondito quello che succede in Nord Africa, o se non hai seguito la storia intricata, talvolta buffonesca, di Gheddafi. Devi prepararti prima, molto prima di partire. Leggere una valanga di giornali, soprattutto stranieri, ogni giorno. Approfondire, creare le tue cartelline sul computer, archiviando il materiale su base tematica: Libia, Afghanistan, Iraq, etc. E poi devi avere una rete di contatti che ti consenta, per esempio, di avere l’ultimo visto e prendere l’ultimo volo disponibile per la Libia una volta iniziata la rivolta.
Parli di relazioni con le ambasciate, con i consolati?
Anche, ma non solo. Talvolta, poi, questi contatti diventano rapporti personali. Magari l’ambasciata non ti dà il visto finché non arriva una chiamata di qualcuno del ministero Esteri. Si tratta di rapporti di fiducia costruiti sulla tua credibilità e serietà professionale, che si sedimentano nel tempo e che al momento giusto sono la chiave di volta. Lo stesso vale per le relazioni personali che instauri sul campo col passare del tempo e dei reportage. Io, per esempio, sono stato decine di volte in Afghanistan e negli anni ho coltivato contatti sul terreno con tutte le parti in lotta. A volte, capita che qualcuno che tu avevi conosciuto in passato diventa in seguito il ministro degli Esteri afgano. Il segreto, quindi, è quello di lavorare non solo sulla parte informativa – che, ripeto, è fondamentale –, ma anche sui contatti personali, che sono altrettanto importanti.
Con quante e quali persone ti muovi sul campo?
Con meno gente possibile. In zona di guerra, chiunque si muove con te è in pericolo. Se possibile, meglio evitare di fare quello che io chiamo il “gruppo vacanze Piemonte”, tanto popolare tra i giornalisti italiani, che hanno la tendenza a muoversi in branco.
Alcuni credono che muoversi in gruppo sia più sicuro.
E invece no. Ognuno ha la sua esperienza, la sua sensibilità: e in base a questo, ciascuno decide se e quanto rischiare. Non sai mai come può reagire un collega, a meno che tu non ci abbia già lavorato o lo conosca da tempo. Meglio non avere la responsabilità della vita di nessuno. Io preferisco fare il lupo solitario, o comunque accompagnarmi a qualcuno – fotografo, cameraman – di cui abbia già testato i nervi saldi sotto al fuoco, che poi è quello che conta.
Premesso questo, è chiaro che quando un giornalista va in zone di guerra di fatto non ha occhi, lingua, orecchie. Deve trovare qualcuno che possa guidarlo: un autista fidato, una guida, un interprete. Talvolta – ma è raro – queste figure coincidono nella stessa persona; il che, per tanti motivi, è ancora meglio. Puoi pagare di più il tuo collaboratore, ti devi affidare a una persona sola, sperando di non aver commesso un errore di valutazione. Il che, purtroppo, può sempre capitare.
In generale, comunque, la tua guida è una figura-chiave; io la chiamo “i miei occhi”. Non è solo un interprete linguistico: è anche qualcuno in grado di annusare l’aria, di cogliere il vero senso delle risposte e il livello di tensione nell’aria. Una brava guida salva la sua pelle e la tua, e soprattutto ti fa capire come stanno davvero le cose. Con molte delle guide con cui ho lavorato nel corso degli anni ho mantenuto rapporti di amicizia, anche perché spesso si lavora sul filo del rasoio. In certe situazioni, uno sbaglio può fare la differenza tra la vita e la morte. Tua e di chi ti accompagna.
I reporter al fronte spesso condividono le informazioni con i colleghi. Tu lo fai?
Sì, se per informazioni intendiamo informazioni sulla sicurezza, su come muoversi, etc. In questo caso, essere un libro aperto è un dovere. Ma i giornalisti italiani tendono invece alla condivisione delle notizie, che è una cosa diversa. Quando ero in Somalia, per esempio, mi sono trovato di fronte a situazioni imbarazzanti in cui quasi sembrava obbligatorio condividere le proprie notizie. Io sono molto contrario a questa mentalità, per motivi assai semplici: prima di tutto, ognuno si prende la responsabilità delle notizie che diffonde; e poi, ci pagano per fare servizi che dovrebbero essere, se non esclusivi, almeno diversi da quelli degli altri. Altrimenti, perché mandare gli inviati? Potremmo starcene tutti in redazione a lavorare con le agenzie.
Quando si lavora come inviati si corre il rischio di essere superficiali?
Certo. Noi siamo sempre superficiali, per definizione. Io sono andato per la prima volta in Afghanistan nel 1983 e l’ultima nel 2013. Credo di avere vissuto tutti i momenti topici della storia afgana. Nondimeno, mi reputo assolutamente superficiale e ho ancora tanti punti di domanda. Forse neanche gli afgani hanno capito la realtà afgana, di certo non l’ho capita appieno io. Per questo mi fanno ridere quei giornalisti che vanno a fare due reportage e quando tornano scrivono un libro.
Come ci si tutela e come si tutela il lettore da questo rischio?
Con un minimo di onestà intellettuale. Limitandosi a fare il cronista ed evitando grandi voli pindarici sui destini del mondo. Il cronista è quel giornalista che consuma le proprie scarpe andando in giro a cercare storie da raccontare. Piccole storie magari, ma che riflettono la storia generale del conflitto. Faccio un esempio. In Iraq ho scattato la foto di un bambino che aveva perso metà del braccio sinistro durante l’invasione delle truppe alleate. La sua famiglia viveva all’ultimo piano di una palazzina di Bassora durante l’avanzata dei carri armati inglesi e sul tetto di questa palazzina c’era una postazione dei fedayyin di Saddam. Un blindato inglese li ha individuati e ha sparato una cannonata, che ha polverizzato la postazione. Purtroppo però alcune schegge sono entrate nell’appartamento sottostante e una ha segato il braccio del bambino. Ecco: secondo me questa piccola storia rifletteva la grande storia del conflitto in Iraq. Era giusto sparare quel colpo o era sbagliato? Io non sono andato lì per sentenziare: mi sono limitato a raccontare i fatti. Proprio come ho fatto di fronte a un sergente della polizia di New York, che si era arruolato come riservista e che era arrivato in Iraq con un elmetto su cui stava scritto: “11 settembre: Dio perdona, io no”. Saddam c’entrava forse qualcosa con l’11 settembre? No, ma io non ho fatto polemiche, né ho dato giudizi.
Alcuni inviati di guerra sembrano quasi avere una dipendenza dalle missioni all’estero.
Certo. E’ una specie di droga che ti entra nel sangue nel momento in cui capisci che questo è il tuo mestiere e la tua vita. Io l’ho capito quando ero ancora molto giovane, nel 1985, in Uganda, di fronte a mucchi, collinette di cadaveri. In un primo momento mi sono detto: «Ma io che cosa ci faccio qui?». A quel punto le possibilità erano due. Potevo tornarmene a casa e trovare un impiego in banca o alle poste. Oppure potevo restare là: filmando, fotografando, prendendo appunti e fumandomi ogni tanto un sigarillo per sopportare il lezzo di quei corpi. Così è stato. E ho capito allora che quella sarebbe stata la mia vita.
Poi, quando sei giovane e torni da una missione, mentre gli altri magari vanno in discoteca, tu ripensi alla guerra e alle storie che ti sei lasciato alle spalle. Hai bisogno di partire di nuovo, diventa una dipendenza.
Si paga uno scotto nel privato?
Io sono stato molto fortunato, anche da questo punto di vista. Dopo un periodo avventuroso da freelance puro e dopo alcune disavventure – tra cui sette mesi in galera a Kabul ed il ritorno in Afghanistan nel 1989 quando un camion militare mi ha ridotto in fin di vita –, mi sono costruito una famiglia con una santa donna che, come dico sempre, “porta la croce”. Abbiamo una figlia, sono riuscito a costruirmi una vita familiare normale e ne vado orgoglioso. In vacanza me ne sto sotto l’ombrellone a Bibione con la mia famigliola e sono felicissimo. Quando sto in Italia, insomma, vivo da piccolo-borghese. Certo, quando parto mi rendo conto che è sempre un patema d’animo per chi resta: ma anche in questo le nuove tecnologie, come Skype, aiutano.
Ti definisci “molto fortunato”. Significa che sei un’eccezione?
In generale ho notato che giornalismo – non solo di guerra – rende più problematica la vita familiare. So di colleghi che si sono dati al bere, per esempio. Altri hanno messo in gioco la loro vita familiare e non sono pochi.
Torniamo alla carriera. Tu hai iniziato da subito come freelance…
Non facevo parte della casta giornalistica (che esiste): avevo iniziato a scrivere nel 1980, il tesserino da pubblicista è arrivato nel 1982. Ma l’esame da professionista l’ho potuto fare solo nel 1990. Ci sono voluti dieci anni e un praticantato svolto in un giornale in lingua italiana del Canton Ticino.
Ma a quel punto quale bisogno avevi di diventare professionista?
Per necessità di contratto. Inoltre, se hai il tesserino in tasca, hai un minimo di copertura in più. Comunque, io sono contrario all’Ordine, almeno per come è strutturato adesso: servirebbe una profonda riforma.
Scuola o gavetta. Cosa consigli a chi inizia?
Tutte e due. Le scuole sfornano disoccupati cronici e, da quanto ho visto, almeno per quanto riguarda il mio campo, il giornalismo di guerra, chi le frequenta non ha idea di cosa si stia parlando. Questo mestiere si impara sul campo, non sui banchi. Ma le scuole ti danno il praticantato. E comunque tutto può servire.
I corsi davvero utili sono invece quelli che ti insegnano a sopravvivere in zone ostili. Un grossissimo problema per i giornalisti italiani inviati al fronte è che da noi non c’è la cultura la sicurezza: solo da poco si va in giro con giubbotti anti-proiettile ed elmetto. Io consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere di frequentare un sano corso di sopravvivenza, che per il 50% si basa sul primo soccorso. Io stesso ne ho seguito uno a Londra, anni fa. Con me c’erano giornalisti della CNN – che devono farlo per obbligo contrattuale, altrimenti non li mandano in zone di guerra –, personale di ong e poliziotti che dovevano partire per il Sudan.
In Italia la figura del freelance è ancora poco popolare. In futuro questa percezione cambierà?
Sì, è un’evoluzione è necessaria. I giornali hanno sempre meno soldi da spendere e, inoltre, i media italiani sono concentrati sul proprio ombelico: non c’è la mentalità della politica estera, se non a spot. Quindi le risorse per gli esteri sono sempre scarse. Il contratto da inviato e da inviato speciale praticamente non esiste più, perché è molto costoso per la testata. Tuttavia, nei giornali e nei tg c’è sempre almeno una notizia di esteri. A quel punto, l’editore può fare una scelta. O si trattano gli esteri dalla scrivania della redazione, lavorando con le agenzie, oppure ci si può affidare a freelance esterni, che grazie alle nuove tecnologie – videocamere piccole, ma di qualità eccezionale, possibilità di fare dirette tramite pc, etc – possono fornire un servizio dal campo a costi contenuti. Insomma, la crisi potrebbe portare editori e giovani giornalisti a venirsi incontro.
Ma i costi a volte sono troppo contenuti… I giovani giornalisti che si propongono come freelance spesso ottengono dai giornali compensi ridicoli.
E’ vero. Però anche i freelance a inizio carriera devono capire che la credibilità e una migliore retribuzione vanno di pari passo e si conquistano portando materiale di qualità. Penso all’esperienza che ho avuto io con l’Albatros. Noi non abbiamo iniziato a lavorare con l’Italia, ma con l’estero. I network americani (Cbs, Abc, etc) ci dicevano: «Se andate in Birmania coi Karen, noi vogliamo il bang bang». Un discorso cinico, certo. Però quando tornavamo e portavamo il «bang bang», con i Karen che rubavano le scarpe ai morti, guadagnavamo la loro fiducia e si creava un rapporto di serietà e affidabilità. Da lì veniva tutto il resto. Certo, all’estero c’è una consuetudine maggiore con la figura del freelance: ma credo che, vista la concomitanza attuale di crisi economica e nuove tecnologie alla portata di tutti, alla fine si troverà un accordo tra offerta e domanda. Vale a dire: remunerazioni dignitose per il freelance e per la testata un prodotto di qualità e a costi minori, che non sia un pastone di agenzie o semplice citizen journalism (che ha molti limiti).
Quindi i compensi crescono proporzionalmente alla credibilità del giornalista.
Certo. Ma anche gli editori devono rendersi conto che per loro far lavorare freelance multimediali è un’opportunità, non una spesa.
Oltre a portare contenuti di qualità, come ci si autopromuove?
Il freelance deve seguire il filone della multimedialità. Il discorso: «Sono un fotografo, faccio belle foto» non vale più. Belle foto ce ne sono tante in giro per il mondo: ma se alla bella foto sei in grado di affiancare un pezzo scritto, e magari anche un piccolo girato per il sito del giornale, allora hai molta meno concorrenza. E puoi chiedere un compenso maggiorato.
Suggerisco poi di andare in posti dove gli altri non vanno, e perderci molto tempo. Per esempio: all’inizio della crisi del 2011 in Libia c’erano centinaia di giornalisti; ma poi sono andati diminuendo, e a un certo punto i reporter italiani si contavano sulle dita di una mano. In quel momento, se fossi stato un giovane freelance, sarei partito zaino in spalla e mi sarei piazzato a Sirte per un mese, insieme ai ribelli. Avrei cercato di mandare ogni tanto qualcosa ai giornali, ma essenzialmente avrei atteso il colpo grosso. Che, in questo caso, alla fine l’hanno fatto i ribelli, riprendendo con un telefonino la cattura e la morte di Gheddafi. Stare un mese a Sirte con i ribelli avrebbe comportato una spesa contenuta: di solito, quando si parte per un’area di crisi, il costo maggiore è rappresentato dall’assicurazione, anche se esistono delle realtà internazionali che garantiscono ai freelance assicurazioni a minor costo. Magari, in un caso come quello che abbiamo ipotizzato, potrebbe essere lo stesso giornale a pagare l’assicurazione del freelance. Del resto, avere un contatto a Sirte, che magari funga anche da stringer per l’inviato della stessa testata eventualmente presente sul posto, può rappresentare una buona opportunità. Poi, se quel freelance mette a segno il colpaccio, tanto meglio per lui e per il giornale.
In zone di guerra le giornaliste donne rischiano più dei colleghi maschi?
Se parliamo nello specifico di giornaliste freelance, sì: il livello di rischio può essere maggiore. Però io ho incontrato anche diverse fotografe di guerra freelance – ormai quasi tutti i fotografi di guerra sono freelance, peraltro – che sono riuscite a realizzare lavori straordinari. Direi, comunque, che il rischio eventualmente maggiorato dipende molto dalle zone in cui bisogna lavorare. Certo, nel mondo islamico per una reporter ci possono essere difficoltà maggiori; ma all’opposto, proprio nei Paesi arabi, talvolta essere donna aiuta. Una giornalista, per esempio, riesce a entrare con maggiore facilità all’interno di case private, dove abitano altre donne. O ancora, quando si intervistano certi personaggi tipo Gheddafi, spesso una donna può osare qualche domanda in più rispetto a un collega maschio. Ma certo accade anche il contrario: a Najaf, dove ero andato a insieme a Gabriella Simoni (che attualmente lavora per Mediaset, ndr) a intervistare i nuovi capi religiosi dell’Iraq, prima di farci entrare, mi hanno detto: «Se viene anche lei, deve coprirsi il capo e stare zitta. E le domande le puoi fare solo tu». A volte i limiti culturali non ti permettono di fare il tuo lavoro o magari ti espongono a rischi maggiori. Comunque, in generale, posso dire che le reporter o camerawoman che incontro sul lavoro, spesso sono molto giovani e hanno una grande determinazione. Sono giornaliste d’assalto.
Se tua figlia ti dicesse: «Voglio fare la giornalista»…?
Le spezzo le gambe! Non in Italia, almeno: non ne vale la pena. I media italiani non hanno la cultura: degli esteri in particolare, ma non solo. Dovrei incoraggiare mia figlia a fare un mestiere bellissimo, certo, ma anche pericoloso, in cui puoi rischiare la vita? Ma perché? E soprattutto: per chi?
Però tu, tornando indietro, rifaresti quello che hai fatto.
Sì, ma evitando alcuni errori. Per esempio, quando ho iniziato a lavorare con l’Italia, mi sono adagiato, dimenticando le testate straniere con cui avevo cominciato. E’ stato un grande sbaglio. Come quando alla fine degli anni Ottanta, dopo la mia prigionia a Kabul, Indro Montanelli mi propose un contratto per il Giornale e io rifiutai: «Voglio continuare a fare il freelance».
Non deve essere stato facile di no a un mito come Montanelli. Tu, peraltro, eri ancora agli inizi…
Proprio perché ero così giovane ho rifiutato. Avevo lottato tanto per emergere come freelance, credevo profondamente in questa sorta di folle libertà e indipendenza.
Tra tutte le storie che hai raccontato ce n’è una che ricordi in modo particolare?
Ci sono tante storie e tanti personaggi indimenticabili, sia brave persone che delinquenti. Tutti i reportage di guerra che ho fatto ce li ho incisi nella memoria, alcuni anche sulla pelle. I sette mesi in carcere a Kabul. L’ultima intervista con ho fatto a Gheddafi, che fu la sua ultima intervista tout court. Non penso che dimenticherò facilmente quella tenda beduina.
Ma come ci sei arrivato a Gheddafi?
Grazie all’esperienza e, come sempre in questo mestiere, grazie al classico colpo di fortuna. Durante la crisi libica, Gheddafi venne a fare una delle sue sceneggiate all’hotel Rixos di Tripoli, dove rilasciò un’intervista alla tv turca Trt. I giornalisti presenti si accalcavano intorno a lui, cercavano di parlargli, di scattare una foto: ma era del tutto inutile. Io, invece, ho preferito guardarmi attorno, e ho individuato una persona del suo entourage che mi sembrava la chiave giusta. E così è stato. Saltava all’occhio, perché era una persona differente dalle altre che accompagnavano il colonnello. Il suo aspetto era diverso, il suo contegno anche: se ne stava in disparte, aveva i modi di un signore. Si presentò dicendomi: «Mi chiamo Missuri, come il fiume». Era un ex ambasciatore che lavorava nella segreteria del colonnello, come suo consigliere per la comunicazione.
Beh, lui, insieme ad altri tasselli, fu la chiave di volta per essere l’unico giornalista italiano (e l’ultimo) a intervistare Gheddafi alla vigilia dei bombardamenti Nato sulla Libia in piena rivolta.
Quando sognavi di fare il giornalista, chi erano i tuoi miti?
I miei miti erano Ettore Mò e Lucio Lami: leggevo i loro libri e reportage, mi sembravano inarrivabili. Invece li ho conosciuti, e ho persino avuto la fortuna di andare in giro insieme a loro. In Pakistan, nelle Filippine, in Angola, etc. Erano inviati vecchio stile che mi hanno insegnato molto, soprattutto sulla serietà di questo mestiere.
Oggi qualcuno fa ancora l’inviato in quel modo?
Qualcuno sì, ma sono pochi. Toni Capuozzo, Lorenzo Cremonesi, Gabriella Simoni, Gian Micalessin hanno raccolto quel testimone.
[continua]
|
|



|
|